Probabilmente avrai sentito parlare della “flora intestinale” come qualcosa di delicato da curare, proprio come chi si prende cura di un giardino. Ma in realtà, nel nostro intestino non crescono piante né fiori. Il termine “flora” è un modo antiquato per descrivere una comunità vivente decisamente diversa: il microbiota intestinale, un microcosmo costituito da batteri, virus, funghi e archea. Questi microrganismi abitano il nostro intestino, convivono con noi e agiscono in sinergia con il nostro organismo, influenzando funzioni metaboliche, difesa immunitaria, salute mentale e perfino predisposizione a certe malattie.
Un viaggio nella storia del microbiota
Per capire l’importanza del microbiota, facciamo un salto nel tempo. Nel 1683, Antonie van Leeuwenhoek, un tessitore autodidatta olandese, fu il primo uomo a osservare microbi viventi usando un microscopio realizzato da lui stesso: li chiamò “animalcules” e li vide nelle feci e nella placca dentale. Fu una scoperta che rivoluzionò la biologia e pose le basi della microbiologiaca moderna. Passarono quasi due secoli prima che Pasteur studiasse i batteri anaerobi nell’intestino, riconoscendo la loro essenziale funzione nelle nostre funzioni vitali. Poi, all’inizio del Novecento, il premio Nobel Metchnikoff propose che alcuni lactobacilli potessero essere “amici” della salute, contrastando quelli che lui riteneva responsabili di un processo di autointossicazione.
Il salto decisivo nel linguaggio moderno giunse nel 2001: il genetista Joshua Lederberg introdusse il termine microbioma, per indicare non solo i microrganismi ma anche il loro materiale genetico, un ambiente condiviso che ci rende parte di un vero ecosistema genomico. In questa visione, l’essere umano non è un individuo isolato ma un insieme composto da tanti co‑abitanti microscopici e interagenti.
Microbiota vs. microbioma: qual è la differenza?
Se immagini il microbiota come un cast di attori impegnati in un grande spettacolo, il microbioma è l’intera messa in scena: copione, scenografia, interazione tra attori e spettatori, e ogni dettaglio dell’ambiente. Il microbiota rappresenta i microrganismi vivi presenti in un luogo – come nell’intestino, sulla pelle o nella bocca – mentre il microbioma include anche il loro DNA e i metaboliti, sostanze chimiche prodotte per vivere e interagire. In alcuni studi si stima che un adulto sano abbia nel colon circa 38.000 miliardi di batteri, per un peso complessivo di oltre 200 grammi, sebbene la cifra esatta vari da persona a persona.
Il metagenoma, infine, è un concetto ancora più ampio: comprende tutto il materiale genetico umano e microbico presente in un ambiente specifico come l’intestino. Grazie allo studio del metagenoma, possiamo non solo identificare “chi c’è”, ma anche capire “che cosa fa”, ossia quali funzioni sono attive.
Il corpo come superorganismo
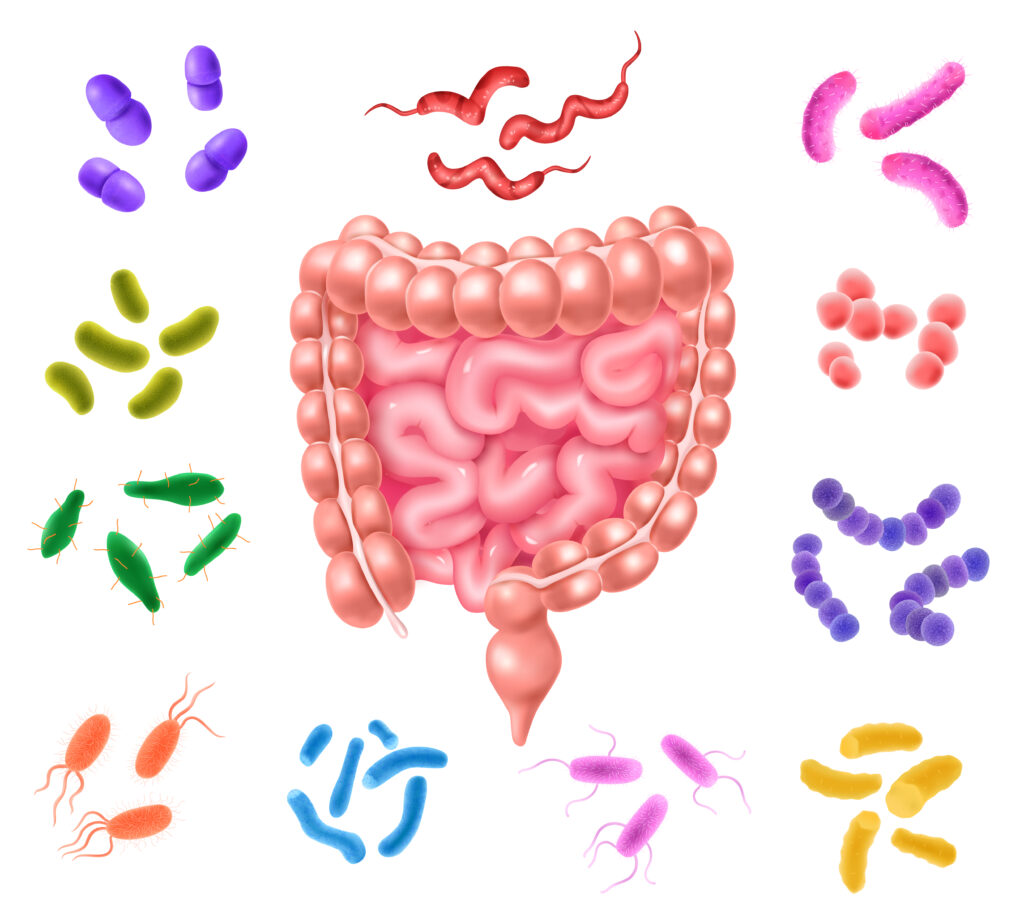
Un termine chiave per cogliere la profondità della relazione tra noi e i nostri microrganismi è holobionte. Significa che l’essere umano e la sua comunità microbica formano un’unica entità integrata, in cui ciascuna parte dipende dall’altra per garantire il corretto funzionamento dell’insieme. Quando questo equilibrio si altera — ad esempio a causa di antibiotici prolungati, stress cronico o abitudini alimentari squilibrate — si parla di disbiosi, ovvero una rottura dell’armonia microbica. In queste condizioni, alcuni batteri normalmente commensali possono assumere un comportamento patobiontico, innescando processi infiammatori e contribuendo allo sviluppo di malattie, anche sistemiche.
Le funzioni vitali del nostro microbiota
Il microbiota intestinale non è un semplice “ospite silenzioso”: è un alleato attivo che partecipa a molte funzioni vitali. Dal punto di vista metabolico, fermenta fibre alimentari non digeribili producendo metaboliti come gli acidi grassi a catena corta, che nutrono le cellule intestinali, regolano il glucosio e l’appetito, e supportano la produzione di vitamine essenziali come la K e alcune del gruppo B (inclusa la B12). Sotto l’aspetto immunitario, stimola la produzione di anticorpi mucosali utili per proteggere le mucose intestinali e modula la reazione infiammatoria tramite molecole anti-infiammatorie. Inoltre, agisce come un sistema di difesa attiva: colonizza lo spazio, sottrae risorse ai patogeni, fa barriera alla loro crescita e preserva l’integrità della mucosa intestinale.
Disbiosi e malattia: cosa succede quando l’equilibrio si spezza
Quando l’equilibrio tra le specie microbiche è compromesso — per antibiotici, dieta scarsa di fibre o stress prolungato — emerge la disbiosi, con conseguenze che possono essere molto serie: da disturbi gastrointestinali (come colite ulcerosa, morbo di Crohn, sindrome dell’intestino irritabile) a condizioni metaboliche come obesità, fino a disturbi neuropsichiatrici quali ansia, depressione o autismo. Studi clinici in modelli animali controllati – come topi gnotobiotici — aiutano a determinare se la disbiosi sia causa o conseguenza della malattia, osservando direttamente gli effetti di un microbiota alterato sull’organismo.
FMT: trapianto di microbiota fecale come terapia innovativa
Il trapianto fecale (FMT, dall’inglese Fecal Microbiota Transplantation) è una procedura terapeutica che prevede l’introduzione nel tratto intestinale di un paziente del materiale fecale di un donatore sano, con l’obiettivo di ripristinare un microbiota funzionale ed equilibrato. È indicata soprattutto nei casi di disbiosi intestinale grave e persistente, in particolare nelle recidive di infezione da Clostridioides difficile (rCDI), un’infezione opportunistica resistente alla terapia antibiotica e potenzialmente fatale, soprattutto nei soggetti immunocompromessi o ospedalizzati.
La logica alla base della FMT è ecologica: reintrodurre una comunità microbica diversificata e stabile capace di competere con i patogeni, ristabilire l’integrità della barriera intestinale e riprendere le funzioni metaboliche e immunoregolatorie alterate.
Il materiale fecale viene donato da soggetti sani, sottoposti a rigoroso screening infettivologico e microbiologico, per escludere la presenza di patogeni, virus emergenti, parassiti e agenti antibiotico-resistenti. Una volta processato in laboratorio e filtrato, il campione può essere somministrato tramite varie vie: enteroclismi (clistere), colonscopia, sondino naso-duodenaleoppure in forma capsulata orale liofilizzata, una modalità più recente e meglio tollerata dal paziente.
Numerose meta-analisi confermano un tasso di successo compreso tra l’87% e il 92% con una sola procedura.
Nuove frontiere in salute:
Ipertensione
Il potenziale terapeutico del microbiota si estende ben oltre il tratto intestinale. Studi emergenti stanno esplorando il ruolo del microbiota intestinale come modulatore sistemico, capace di influenzare organi e funzioni a distanza, attraverso la produzione di metaboliti, la modulazione dell’infiammazione e l’interazione con il sistema nervoso e ormonale. In questo contesto, sia il trapianto di microbiota fecale (FMT) sia l’uso di consorzi batterici specifici si stanno rivelando strumenti promettenti anche in condizioni extra-intestinali, spesso difficili da trattare con le terapie convenzionali.
Nel campo dell’ipertensione arteriosa, ad esempio, uno studio clinico ha mostrato che la FMT da donatori normotesi a pazienti ipertesi è stata in grado di ridurre transitoriamente la pressione arteriosa sistolica. L’effetto sembrerebbe mediato da una ricomposizione favorevole del microbiota e da una modificazione dei metaboliti circolanti, come gli acidi grassi a catena corta, che influenzano il tono vascolare e l’infiammazione endoteliale. Tuttavia, l’effetto è risultato non persistente nel tempo, evidenziando la necessità di strategie a lungo termine per il mantenimento dell’equilibrio microbico e dei suoi effetti benefici.
Salute mentale
Anche in psichiatria biologica stanno emergendo evidenze sorprendenti. Esperimenti su animali mostrano che il trasferimento del microbiota intestinale da pazienti con depressione maggiore può indurre, nei topi riceventi, sintomi comportamentali compatibili con uno stato depressivo, come l’anedonia e l’apatia. Questi effetti sono associati a riduzioni di aminoacidi neuroattivi, come il triptofano, e alla deplezione di ceppi considerati benefici, come Bifidobacterium e Faecalibacterium prausnitzii. Tali risultati rafforzano l’ipotesi del cosiddetto asse intestino–cervello, una rete bidirezionale che collega intestino, sistema nervoso centrale, immunità e neurotrasmettitori. È un campo in rapida espansione, che apre scenari terapeutici radicalmente nuovi per ansia, depressione e disturbi dello spettro autistico.
Fertilità
Non meno interessante è il ruolo emergente del microbiota nella fertilità e nella medicina riproduttiva. In modelli sperimentali animali, il trapianto del ceppo Lactobacillus vaginalis ha migliorato in modo significativo il tasso di impianto embrionale e la dimensione della figliata. I suoi metaboliti attivi, come galangina e daidzeina, sembrano favorire l’adesione dell’embrione all’endometrio e sostenere un ambiente uterino più recettivo, modulando l’infiammazione locale e la segnalazione ormonale. Questi dati potrebbero avere implicazioni future nella gestione dell’infertilità idiopatica e nei fallimenti di impianto in procreazione medicalmente assistita, spingendo verso un’integrazione microbiotica nelle strategie terapeutiche per la salute riproduttiva femminile.
Verso una medicina ecologica e personalizzata
La crescente consapevolezza del ruolo del microbiota ha aperto la strada a una medicina personalizzata e predittiva, fondata non solo sul genoma umano ma anche sul profilo microbico individuale. In questo scenario si inserisce il CLOUD test (Clustering of Local Outliers of Unbalanced Dysbiosis), uno strumento diagnostico avanzato pensato per valutare la salute del microbiota in modo dinamico ed ecologicamente sensibile.
A differenza delle analisi tradizionali, che si limitano a rilevare la presenza o l’assenza di determinati ceppi batterici, il CLOUD test considera due parametri chiave: la conformità (quanto il microbiota di un individuo somiglia a un modello sano di riferimento) e la stabilità (quanto quel profilo resta coerente nel tempo). Questo approccio tiene conto della naturale variabilità tra individui e consente di distinguere un microbiota sano, instabile o francamente disbiotico.
La sua forza sta nel valutare le relazioni tra i microrganismi, e non solo la loro composizione. È un cambio di paradigma: non basta sapere “chi c’è”, ma serve capire “come convivono” e “se l’ecosistema tiene”. Questo è particolarmente utile nei casi clinici complessi, dove l’instabilità microbica può precedere o accompagnare malattie croniche, disturbi infiammatori o alterazioni del metabolismo.
Il CLOUD test, validato anche in ambito clinico (per esempio nel monitoraggio del trapianto fecale per infezioni da C. difficile), offre oggi una base oggettiva per interventi terapeutici mirati, dall’uso personalizzato di probiotici o postbiotici fino a modifiche dietetiche calibrate sul profilo microbico individuale.
Considerazioni finali e prospettive
La nostra salute non può più essere vista solo come proprietà delle nostre cellule. Il microbiota è oggi riconosciuto come un partner attivo nella medicina moderna.
Comprenderlo, proteggerlo e integrarlo in un modello terapeutico individuale è sinergia tra biologia e tecnologia, medicina e sostenibilità. Come affermava Joshua Lederberg: siamo ecosistemi metabolici condivisi, ed è responsabilità nostra prenderci cura di questo ecosistema per garantire salute non solo a livello individuale, ma per il benessere collettivo.
Per ulteriori informazioni sul microbiota intestinale, puoi consultare il seguente articolo: Il microbiota intestinale: 5 cose che devi assolutamente sapere!

