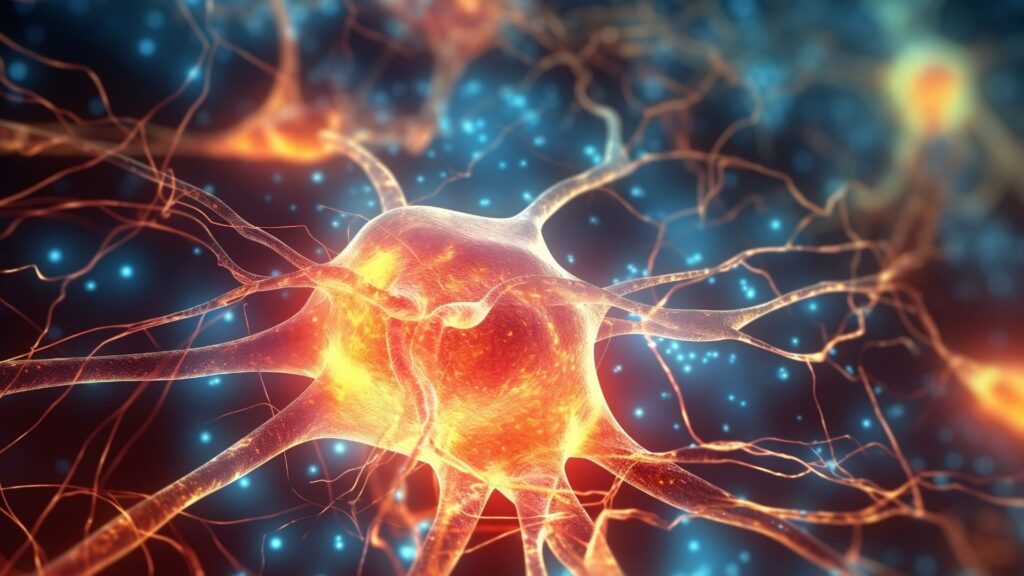Di Maria Caso
Negli ultimi anni, la scienza ha acceso i riflettori su un legame sorprendente: quello tra cervello e infiammazione. Non si tratta più di una semplice ipotesi, ma di una pista concreta che potrebbe rivoluzionare il modo in cui comprendiamo disturbi come Alzheimer, sclerosi multipla, depressione e molte altre condizioni.
La visione tradizionale, che vedeva l’infiammazione come una risposta temporanea a infezioni o traumi, è ormai superata. Oggi sappiamo che l’infiammazione può diventare cronica, silenziosa e persistente, colpendo il cervello anche in assenza di agenti patogeni. Stress, traumi, malattie autoimmuni e degenerative possono innescare una risposta immunitaria che, anziché proteggere, finisce per danneggiare le cellule nervose.
In questo articolo, ti guiderò alla scoperta del legame tra cervello e infiammazione, analizzando le ultime evidenze scientifiche e offrendo spunti concreti per la prevenzione e la salute neurologica. Perché conoscere il funzionamento del nostro corpo non è solo un atto di curiosità, ma una scelta di consapevolezza e benessere duraturo.
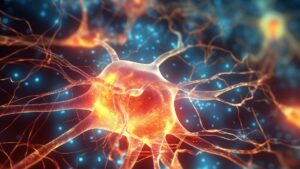
Cervello e infiammazione: meccanismi d’azione e attori principali
L’infiammazione è un meccanismo di difesa fondamentale, attivato dal nostro organismo in risposta a danni tissutali causati da infezioni, traumi o agenti chimici. Il suo scopo è ripristinare l’equilibrio e promuovere la guarigione attraverso una serie di reazioni cellulari e molecolari.
Questa risposta è orchestrata dal sistema immunitario, un complesso network di cellule e organi capaci di riconoscere e neutralizzare minacce esterne. Sebbene per decenni si sia pensato che il cervello fosse dotato di un propria immunità innata, oggi sappiamo che il sistema immunitario periferico dialoga attivamente con il cervello, contribuendo alla sua difesa e al suo funzionamento.
Nel Sistema Nervoso Centrale, l’infiammazione assume caratteristiche uniche e prende il nome di neuroinfiammazione. A causa della limitata capacità rigenerativa del tessuto nervoso e della vulnerabilità dei neuroni, la risposta infiammatoria cerebrale è altamente regolata: persino l’ingresso di cellule immunitarie periferiche è controllato per evitare danni irreversibili alle delicate strutture neuronali.
L’infiammazione del cervello può essere benefica in fase acuta, ma se persiste nel tempo, può contribuire allo sviluppo di malattie neurodegenerative, psichiatriche e del neurosviluppo. Comprendere questi meccanismi è essenziale per sviluppare nuove strategie terapeutiche e promuovere una salute cerebrale consapevole.
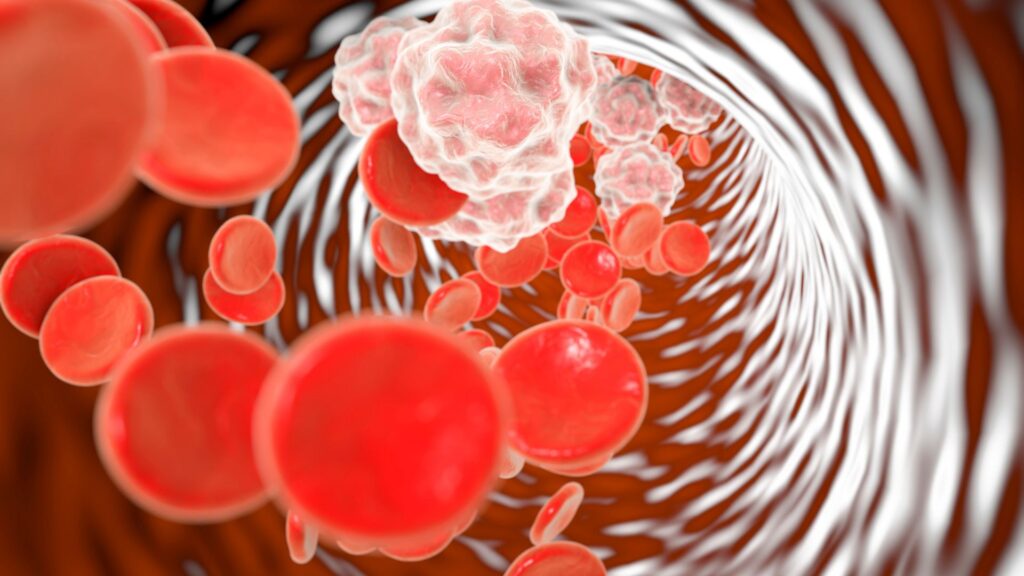
Neuroinfiammazione: come funziona davvero?
Come il sistema immunitario periferico, anche quello cerebrale si attiva in presenza di infezioni, traumi o danni tissutali, ma lo fa con meccanismi più selettivi e regolati. Come abbiamo visto, il sistema immunitario periferico non è escluso da questo processo: al contrario, dialoga costantemente con il cervello attraverso segnali molecolari e, in condizioni patologiche, può contribuire all’attivazione della neuroinfiammazione.
Ecco i principali protagonisti dell’infiammazione nel cervello:
- Barriera ematoencefalica (BEE)
È la prima linea di difesa contro patogeni e molecole potenzialmente dannose. È costituita dalle cellule endoteliali, che rivestono i capillari cerebrali tenute insieme da giunzioni strette, strutture specializzate nel saldare le membrane di cellule adiacenti. Esse regolano selettivamente il passaggio di cellule e molecole dal sangue al tessuto nervoso. - Astrociti
Sono le cellule gliali più numerose nel cervello e svolgono funzioni neuroprotettive su più fronti. Oltre a mantenere l’equilibrio omeostatico del microambiente neuronale, in caso di danni o minacce, attivano la risposta immunitaria, attraverso la secrezione di molecole pro-infiammatorie e contribuiscono all’eliminazione dei detriti e al ripristino di struttura e funzione dei neuroni coinvolti. - Microglia
Considerata la vera sentinella immunitaria del cervello, la microglia è l’insieme di cellule gliali, che monitora costantemente l’ambiente cerebrale. In caso di danno, si attiva, rimuove detriti cellulari e rilascia le citochine, molecole pro-infiammatorie. È coinvolta sia nella risposta acuta che nei processi infiammatori cronici, alla base di molte malattie neurologiche.
Risposta neuroinfiammatoria e stress ossidativo
La risposta infiammatoria, mediata dalle molecole pro-infiammatorie, aumenta la permeabilità della barriera ematoencefalica. Il risultato è un rilascio di ulteriori cellule immunitarie periferiche, i leucociti, che arrivano in soccorso per ripristinare equilibrio e funzione del tessuto nervoso danneggiato.
L’infiammazione al cervello causa stress ossidativo, dovuto al rilascio di radicali liberi, molecole instabili e altamente reattive. Esse svolgono il ruolo importante di combattere il danno e debellare agenti estranei, cellule morte e detriti.
I radicali liberi attaccano anche le componenti fondamentali delle cellule, come il DNA, le membrane cellulari e le proteine, compromettendone struttura e funzione. Se tale processo persiste nel tempo, si verifica un danneggiamento progressivo dei tessuti nervosi, che può superare la capacità dei sistemi di riparazione cellulare di ristabilire l’equilibrio.
Cervello e infiammazione: come l’immunità opera nelle malattie neurologiche
Nonostante le crescenti evidenze di una correlazione tra cervello e infiammazione, molti aspetti restano ancora da chiarire. In particolare, la ricerca sulle malattie neurologiche si sta concentrando sul ruolo delle cellule microgliali, che, in alcune condizioni, possono subire alterazioni strutturali e funzionali, contribuendo all’instaurarsi di uno stato infiammatorio cronico.
Una delle ipotesi più accreditate è che la microglia venga attivata in risposta a danni alle strutture nervose causati da patologie neurodegenerative, autoimmuni o infettive. In fase iniziale, questa attivazione ha una funzione neuroprotettiva: l’immunità innata si mobilita per riparare i danni e favorire la sopravvivenza neuronale. Tuttavia, se la malattia persiste, si verifica un’amplificazione della risposta infiammatoria. L’iperattivazione della microglia e di altre cellule immunitarie può, allora, generare un ambiente tossico, aggravando la degenerazione neuronale.
Esistono, tuttavia, evidenza a sostegno dell’ipotesi che l’infiammazione possa essere causa stessa della patologia. Da questa prospettiva, sarebbero i meccanismi patologici ad innescare l’infiammazione del cervello.
La neuroinfiammazione, quindi, può essere sia una causa che una conseguenza delle malattie neurologiche e la sua manifestazione varia in base alla patologia.
Nelle prossime sezioni analizzeremo nel dettaglio le principali condizioni cliniche in cui infiammazione e sistema immunitario giocano un ruolo chiave.
Malattie neurodegenerative e infiammazione
Cervello e infiammazione sembrano svolgere un ruolo sincronico nella neurodegenerazione, condizione comune a diverse malattie neurologiche e caratterizzata dal deterioramento delle cellule nervose, con conseguente perdita della loro funzione.
Il legame tra neuroinfiammazione e neurodegenerazione sta emergendo sempre più forte negli studi degli ultimi anni. Le cellule della microglia e la BEE attivano una risposta infiammatoria in presenza di lesioni, danni o accumuli di detriti, quali gli accumuli proteici tipici di alcune patologie,
Questo processo, se in un primo momento risulta salvifico, favorendo l’eliminazione dei detriti e il ripristino della funzione cerebrale, se perpetuato, causa un netto peggioramento della malattia: uno stato infiammatorio cronico, come abbiamo visto, contribuisce al deterioramento neuronale.

Malattia di Alzheimer
Tra le patologie neurodegenerative più note e studiate, la malattia di Alzheimer è caratterizzata dall’accumulo anomalo di due tipi di proteine:
- beta-amiloide: si aggrega in placche che si accumulano tra i neuroni;
- tau: si deposita all’interno dei neuroni, formando grovigli.
Si tratta di una condizione estremamente complessa, in cui intervengono numerosi fattori e meccanismi biologici ancora oggetto di studio. Le cellule immunitarie, in particolare la microglia, si concentrano attorno a questi aggregati proteici, contribuendo al processo di infiammazione del cervello.
Alcuni mediatori infiammatori possono favorire la stabilizzazione e l’accumulo delle placche, accelerando la progressione della malattia. Altri partecipano alla risposta infiammatoria che, se cronicizzata, può evolvere in neurotossicità, danneggiando ulteriormente i neuroni e aggravando il quadro clinico.
Morbo di Parkinson
La fisiopatologia del morbo di Parkinson condivide alcuni tratti con quella dell’Alzheimer, in particolare per quanto riguarda i meccanismi neuroinfiammatori. In questo caso, la degenerazione colpisce i neuroni dopaminergici, responsabili della produzione di dopamina, un neurotrasmettitore essenziale per il controllo del movimento.
In fase iniziale, la neuroinfiammazione può avere un ruolo protettivo: le cellule microgliali si attivano per riparare i danni e ristabilire l’equilibrio del sistema nervoso. Tuttavia, se la risposta immunitaria diventa eccessiva o prolungata, si verifica una iperattivazione della microglia e di altre cellule immunitarie, che può generare un ambiente tossico e contribuire alla progressione della malattia.
Le evidenze più recenti suggeriscono che la neuroinfiammazione preceda la degenerazione dei neuroni dopaminergici e non ne sia semplicemente una conseguenza. Questo ribalta la visione tradizionale e apre nuove prospettive terapeutiche, mirate a modulare la risposta infiammatoria prima che si instaurino danni irreversibili.
Sclerosi laterale amiotrofica (SLA)
La sclerosi laterale amiotrofica (SLA) è una malattia neurologica rara, in cui l’infiammazione del cervello è un elemento chiave della patogenesi. La malattia colpisce i motoneuroni, portando progressivamente a disturbi motori, fino alla paralisi.
Studi recenti hanno evidenziato che la microglia, in fase iniziale, tenta di proteggere i neuroni, ma, con il progredire della malattia si trasforma in un agente lesivo, contribuendo alla lore stessa degenerazione.
L’attivazione cronica della microglia, associata a disfunzioni e accumulo di proteine anomale, crea un ambiente infiammatorio che accelera la morte cellulare. Anche in questo caso, l’infiammazione non è solo una conseguenza, ma potrebbe rappresentare un fattore scatenante della neurodegenerazione. La neuroinfiammazione, quindi, potrebbe essere presa in considerazione come nuovo target terapeutico per la SLA.
Malattie neurologiche autoimmuni
Il legame tra cervello e infiammazione di manifesta anche nelle malattie autoimmuni. Si tratta di patologie croniche che colpiscono il sistema nervoso centrale e periferico, accomunate da una disfunzione del sistema immunitario, che attacca erroneamente cellule e strutture nervose riconoscendole come estranee. Questo processo genera un’infiammazione cronica, che compromette progressivamente la funzionalità del tessuto nervoso.
La forma più comune è la sclerosi multipla (SM), causata da una risposta immunitaria diretta contro la mielina, la guaina che riveste le fibre nervose e consente la trasmissione rapida degli impulsi elettrici. La demielinizzazione può interessare sia i neuroni del cervello che quelli del midollo spinale, rallentando o bloccando la comunicazione tra le cellule nervose.
In condizioni fisiologiche, gli oligodendrociti, cellule gliali responsabili di produrre e rigenerare la mielina, assolvono perfettamente alla propria funzione. Tuttavia, in presenza di infiammazione persistente, la capacità rigenerativa della mielina risulta compromessa.
Studi recenti hanno dimostrato che la microglia, inizialmente coinvolta nella riparazione, può attivare gli astrociti in modo disfunzionale, ostacolando la maturazione degli oligodendrociti e la ricostruzione della guaina mielinica. L’ambiente infiammatorio, quindi, non solo danneggia la mielina, ma impedisce anche i meccanismi di riparazione endogeni.
Cervello e infiammazione: fattori di rischio e prevenzione
Come abbiamo visto, la comprensione completa del legame tra cervello e infiammazione è ancora lontana. Tuttavia, una certezza è emersa con forza: uno stato infiammatorio cronico può essere dannoso e debilitante, sia quando si manifesta nel cervello, sia in aree periferiche dell’organismo.
Sebbene i meccanismi infiammatori siano spesso innescati da processi patologici di origine genetica o ereditaria, non va sottovalutato il peso dei fattori ambientali. Lo stile di vita moderno, caratterizzato da stress cronico, sedentarietà, alimentazione pro-infiammatoria e esposizione a inquinanti, può contribuire a una neuroinfiammazione cronica di basso grado, che, nel tempo, predispone a potenziali malattie e degenerazione neuronale.
Per questo motivo, è fondamentale conoscere i principali fattori di rischio associati all’infiammazione del cervello, così da adottare comportamenti preventivi e uno stile di vita adeguato alla salute cerebrale.
Quali sono cause e fattori di rischio delle neuroinfiammazione?
L’infiammazione del Sistema Nervoso Centrale (SNC) e Periferico (SNP) può essere provocata da molteplici fattori. Tra i più rilevanti troviamo:
- Infezioni cerebrali e periferiche
Virus, batteri e altri agenti patogeni possono superare la barriera ematoencefalica (BEE) e attivare una risposta immunitaria nelle strutture nervose. Inoltre, un sistema immunitario alterato può generare uno stato infiammatorio diffuso, che coinvolge anche il SNC. - Traumi cerebrali e lesioni
Danni al cervello o al midollo spinale innescano una risposta infiammatoria mirata alla riparazione dei tessuti. Tuttavia, se prolungata, essa può diventare cronica e contribuire alla degenerazione neuronale. - Malattie autoimmuni e neurodegenerative
Come abbiamo visto, possono indurre una risposta infiammatoria a causa dei danni neuronali. - Stress cronico
Causa un rilascio persistente di cortisolo, l’ormone dello stress, che altera la risposta immunitaria, causando un’attivazione disfunzionale di microglia e astrociti. Il risultato può essere un deterioramento dei neuroni con conseguenti effetti su abilità cognitive, funzioni esecutive e decisionali, e umore - Microbiota intestinale
L’asse intestino-cervello è entrato a pieno titolo tra i fattori di rischio di molte condizioni patologiche. Il microbiota intestinale, infatti, comunica costantemente con il cervello attraverso vie immunitarie, ormonali e neurali. Una disbiosi intestinale può contribuire alla neuroinfiammazione, influenzando l’umore, la memoria e la vulnerabilità a disturbi neurologici.

Prevenzione e stili di vita antinfiammatori
La prevenzione di un’alterazione del sistema immunitario e dell’infiammazione al cervello cronica parte da uno stile di vita consapevole e antinfiammatorio. Ecco alcune strategie efficaci:
- Alimentazione
L’asse intestino-cervello gioca un ruolo cruciale nei processi infiammatori. Una dieta ricca di fibre, probiotici e polifenoli favorisce l’equilibrio del microbiota intestinale, rafforza la barriera intestinale e ne riduce la permeabilità, contribuendo a una minore attivazione immunitaria. Questo si traduce in benefici per l’umore, la memoria e la salute cerebrale. - Sonno regolare e rigenerante
Durante il sonno, il cervello attiva meccanismi di “pulizia” come il sistema linfatico, che elimina tossine e detriti cellulari. Dormire 7–8 ore per notte, evitare schermi prima di coricarsi e mantenere una routine costante aiuta a ridurre l’infiammazione cerebrale. - Vitamina D: luce per il cervello
La vitamina D è fondamentale non solo per la salute ossea, ma anche per la regolazione del sistema immunitario e del ritmo circadiano. Recenti studi hanno evidenziato un ruolo di questa vitamina come fattore neuroprotettivo. Essa sembrerebbe modulare il rilascio di molecole pro-infiammatorie in diverse malattie neurologiche. Fare il pieno di vitamina D, può, quindi, prevenire la vulnerabilità a disturbi neurologici. - Gestione dello stress
Lo stress cronico favorisce il rilascio di cortisolo, che può attivare in modo disfunzionale le cellule immunitarie del cervello. Attività come yoga, meditazione, camminate nella natura e sport moderato aiutano a ridurre lo stress e a proteggere il sistema nervoso. - Attività fisica regolare
L’esercizio fisico stimola la produzione di molecole antinfiammatorie, migliora la circolazione cerebrale e favorisce la neuroplasticità. Anche una semplice camminata quotidiana può avere effetti benefici sul tono dell’umore e sulla salute cognitiva. - Prevenzione e monitoraggio
In presenza di familiarità per malattie neurologiche o autoimmuni, è consigliabile effettuare controlli periodici. Inoltre, è sempre consigliabile adottare comportamenti igienici mirati per ridurre il rischio di infezioni, che potrebbero attivare una risposta infiammatoria.
Conclusione e sviluppi futuri
Cervello e infiammazione sono legati da un filo invisibile, che solo negli ultimi anni la ricerca scientifica ha iniziato a svelare. È ormai chiaro che uno stato infiammatorio cronico può avere effetti dannosi e debilitanti sull’organismo, in particolare sul sistema nervoso. Ma ciò che sta emergendo con forza è che il cervello stesso può influenzare il sistema immunitario, modulandone l’attività attraverso segnali neurali, ormonali e cognitivi.
Il legame tra sistema immunitario e malattie neurologiche non è più una semplice ipotesi: è una realtà complessa, dinamica e ancora in fase di esplorazione. Le ricerche in corso offrono la prospettiva di nuove terapie, che puntino su approcci integrati e che considerino il cervello non solo come vittima, ma anche come parte attiva nella regolazione dell’infiammazione.
In questo scenario, vivere con consapevolezza, adottando uno “stile di vita antinfiammatorio”, curando il sonno, l’alimentazione e la salute mentale , diventa il primo passo per proteggere il nostro cervello e il suo delicato equilibrio immunitario.
Il cambiamento parte da te.
Condividi questo articolo sul legame tra cervello e infiammazione e lascia il tuo consiglio per uno stile di vita antinfiammatorio.
Maria Caso – MSc Neuroscienze, Junior Copywriter
Bibliografia e sitografia
- Dhapola R, Hota SS, Sarma P, Bhattacharyya A, Medhi B, Reddy DH. Recent advances in molecular pathways and therapeutic implications targeting neuroinflammation for Alzheimer’s disease. Inflammopharmacology. 2021 Dec;29(6):1669-1681. doi: 10.1007/s10787-021-00889-6. Epub 2021 Nov 23. PMID: 34813026; PMCID: PMC8608577. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34813026/
- Araújo B, Caridade-Silva R, Soares-Guedes C, Martins-Macedo J, Gomes ED, Monteiro S, Teixeira FG. Neuroinflammation and Parkinson’s Disease-From Neurodegeneration to Therapeutic Opportunities. Cells. 2022 Sep 17;11(18):2908. doi: 10.3390/cells11182908. PMID: 36139483; PMCID: PMC9497016. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36139483/
- Duncan GJ, Ingram SD, Emberley K, Hill J, Cordano C, Abdelhak A, McCane M, Jenks JE, Jabassini N, Ananth K, Ferrara SJ, Stedelin B, Sivyer B, Aicher SA, Scanlan TS, Watkins TA, Mishra A, Nelson JW, Green AJ, Emery B. Remyelination protects neurons from DLK-mediated neurodegeneration. Nat Commun. 2024 Oct 23;15(1):9148. doi: 10.1038/s41467-024-53429-5. PMID: 39443516; PMCID: PMC11500002. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11500002/
- https://www.aism.it/sclerosi_multipla_nuova_luce_sul_ruolo_della_microglia_nella_riparazione_della_mielina
- https://www.sanitainformazione.it/dallautismo-alla-schizofrenia-il-ruolo-della-neuroinfiammazione-nelle-malattie-psichiatriche/
- https://fondazionehumanitasricerca.it/il-rapporto-tra-infiammazione-e-malattie-del-cervello-dal-neurosviluppo-allinvecchiamento/